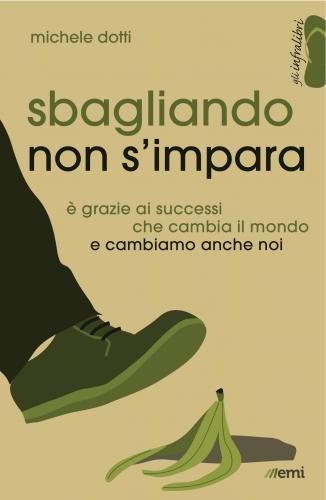Se ve lo foste perso in diretta, ecco il mio intervento in studio a Geo, su Rai3, per presentare il mio nuovo libro “Un segreto difficile da mantenere” (Erga edizioni) e riflettere sulle paure e speranze dei giovani rispetto al futuro.
Archivio tag: libro
Un segreto difficile da mantenere
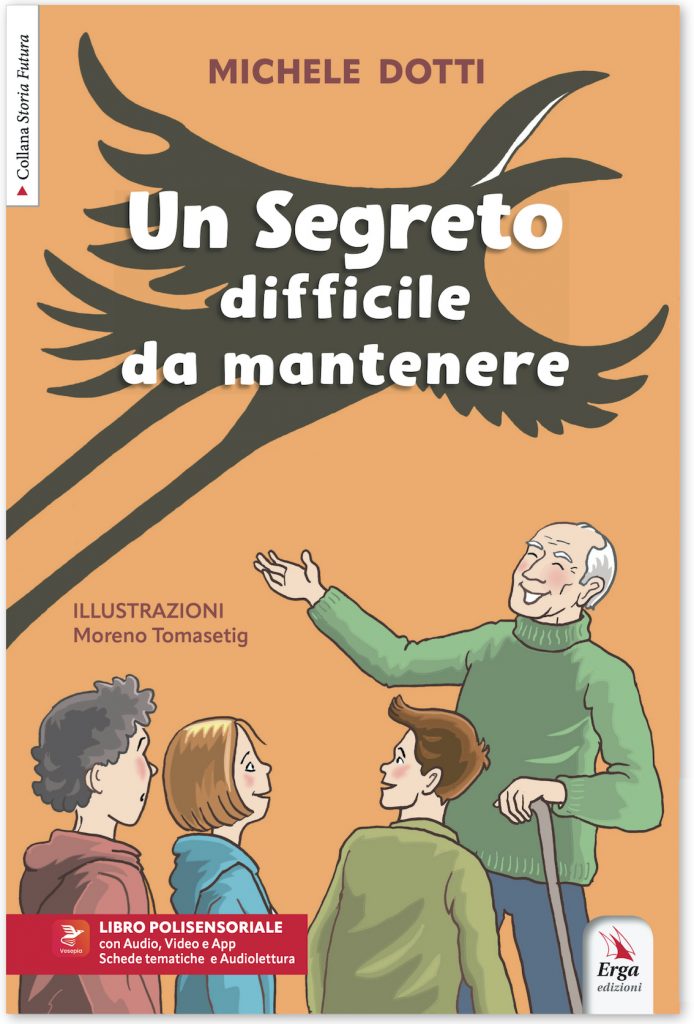 Amici, è appena uscito il mio nuovo libro, disponibile in tutte le librerie. Si tratta del mio primo romanzo per ragazzi.
Amici, è appena uscito il mio nuovo libro, disponibile in tutte le librerie. Si tratta del mio primo romanzo per ragazzi.
Un segreto difficile da mantenere – questo il titolo – è un volume polisensoriale (con audio, video, schede tematiche e audioletture), con bellissime illustrazioni a cura di Moreno Tomasetìg, edito da Erga edizioni.
È un libro largamente autobiografico che intende offrire ai ragazzi una visione alternativa del mondo e della storia, per restituire loro il sacrosanto diritto a sperare in un domani migliore e la voglia, conseguente, di impegnarsi per realizzarlo.
Il testo è leggero, a tratti ironico, ma anche profondo e ricco di contenuti e contiene numerose schede didattiche interattive di approfondimento, con tutti i dati a sostegno di quanto scritto, ad affiancare le emozioni, sostenendole anche su un piano razionale.
L’intento è quello di contribuire – insieme alla scuola e alla famiglia – a ridimensionare quell’ansia terribile, e tanto diffusa, che rischia di rubare ai nostri giovani le migliori energie e i migliori anni, spegnendoli e rendendo grigio un mondo che potrebbe invece essere a colori.
Sono ormai numerose infatti le ricerche che ci dicono quanto i nostri ragazzi siano ansiosi e insicuri, spaventati da un futuro che appare loro sempre più cupo.
Questa visione della vita nasce principalmente dall’informazione di cui dispongono: i mass media non fanno che trasmettere cattive notizie (considerate la prima causa di ansia da Eurodap, l’Associazione europea disturbo da attacchi di panico) e anche l’immaginario collettivo sul futuro, così come è presentato nei film, nelle serie tv e in larga parte anche nella letteratura, è quasi sempre apocalittico o post-apocalittico. Ora va di moda definirlo distopico.
Walt Disney diceva: “Se puoi sognarlo, puoi farlo.” Ma come possiamo pensare di riuscire a realizzare un domani migliore, se non lo immaginiamo mai?”
Se analizziamo i dati, in prospettiva storica e con un approccio scientifico, ci accorgiamo che per molti aspetti il mondo non sta affatto peggiorando.
Anzi, paradossalmente, negli ultimi decenni si sono fatti più progressi su un piano sociale, culturale, dei diritti e anche materiale di quanti non se ne siano realizzati nei secoli o addirittura millenni precedenti. Certo, le conquiste non sono mai definitive, vanno quindi consolidate e soprattutto rese più sostenibili da un punto di vista ecologico. Ma riconoscere che queste ci sono mi pare il primo, essenziale, passo per sognare che si possa continuare a migliorare ancora.
___________________________________
Per le classi che adottano Un segreto difficile da mantenere saranno disponibili molti contenuti extra nella sezione riservata ai docenti del sito www.vesepia.com: PERCORSI DIDATTICI – ESERCIZI E LEZIONI STRUTTURATE – COPIONE TEATRALE SCOLASTICO
Gli argomenti trattati sono:
Ecologia, Intercultura, Pace, Informazione, Progressi sociali, Fraternità, Ascolto, Storia, Consumismo, Fretta, Attesa, Pazienza, Paure, Felicità.
È disponibile anche l’audiolettura del libro tramite l’App gratuita Vesepia.
___________________________________
Sinossi
Anno 2070. Il mondo è cambiato, per fortuna in meglio.
Un nonno, ogni sera, racconta al nipotino Andrea storie divertenti e avventure della sua gioventù, parlandogli dei problemi del passato, ormai superati, che appaiono al piccolo davvero incredibili. Anche il nipote racconta le sue giornate a scuola e molto altro. Dal loro scambio emergono i principali cambiamenti avvenuti nel tempo sia sul piano sociale (pace, ambiente, intercultura…) sia su un piano più intimo e personale. Ma una minaccia, imprevista, incombe sul nonno. Questa volta toccherà al nipote salvarlo.
Un messaggio di ottimismo (che si fa concreto nelle schede interattive di approfondimento sui temi trattati) per promuovere nei ragazzi la speranza in un futuro migliore e l’impegno affinché questo possa realizzarsi.
.
Acquista online il libro “Un segreto difficile da mantenere”
A Geo per Ecofuturo e per il mio nuovo libro
Se ve lo foste perso in tv, ecco il video del mio intervento a Geo, su Rai3, ospite in studio di Sveva Sagramola, per presentare le tante proposte di Ecofuturo Festival e il mio nuovo libro “La terra che salva la Terra“, scritto insieme all’amico Fabio Roggiolani, con tanti contributi importanti e la prefazione di Rattan Lal, Premio Nobel per la Pace con l’IPCC.
▶️ Qui potete rivedere l’intera puntata.
▶️ Qui gli streaming di tutte le sessioni del Festival.
▶️ E qui la scheda del libro.
Sai fare a leggere?
Sbagliando non si impara!
E’ con grande piacere che annuncio l’uscita, a breve, del mio nuovo libro “Sbagliando non si impara”, frutto di una riflessione che porto avanti da diversi anni e che ho voluto approfondire e sistematizzare – per poterla condividere con tutti – in questo saggio leggero ed ironico, che uscirà in gennaio per l’editrice EMI.
“Se fosse vero che sbagliando si impara, come ci hanno sempre ripetuto, dovremmo essere tutti perfetti!
Invece continuiamo a ripetere ogni giorno gli stessi errori, senza neppure troppa fantasia.
Questo accade perché in realtà è solo dai successi che nasce il cambiamento, a tutti i livelli: personale, sociale, culturale…
Questo libretto ci mostra come imparare a riconoscerli, crearli e replicarli.
Come farne insomma una regola nella nostra vita, anziché una eccezione.”
E questo è l’indice del libro, che è già tutto un programma:
1. Chi cerca non trova
2. Sbagliando non si impara
3. Sbagliare è umano, errare è divino
4. Chi fa da sé fa per sé
5. Tutti sono indispensabili, qualcuno è importante
6. Mogli e buoi dei paesi suoi
7. Mangia come parli
8. Peggio soli che ben accompagnati
9. Ambasciator porta pena
10. Prima il piacere, insieme al dovere
11. In salita tutti i Santi aiutano
12. Non perdere la bussola… o la mappa
13. Ognuno è perfetto
14. Ricordati che devi sbagliare!
15. Chi non cerca trova
Nelle prossime settimane pubblicherò anche qualche estratto…
Educare, amare e… saltare nelle pozzanghere
Sta uscendo con “Produzioni dal basso” il mio nuovo libro intitolato un po’ ironicamente “Educare, amare e saltare nelle pozzanghere”.
Si tratta di un manuale per una formazione attiva e ludica nel quale, sotto forma di schede, sono raccolti tanti strumenti che in questi anni, insieme ad alcuni colleghi di Kaleidos, abbiamo affinato nella formazione con gli adulti, specialmente con animatori, educatori, insegnanti e genitori.
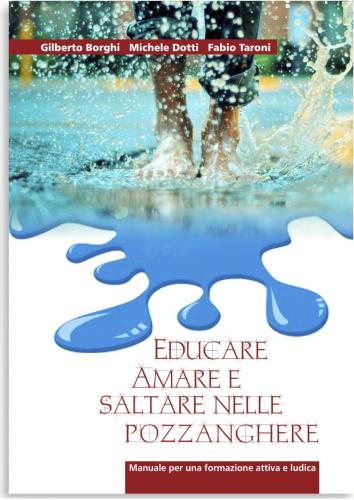 I temi trattati sono la creatività, la comunicazione, la diversità e le relazioni.
I temi trattati sono la creatività, la comunicazione, la diversità e le relazioni.
L’ho scritto insieme agli amici Fabio Taroni e Gilberto Borghi.
Abbiamo scelto di pubblicarlo con “Produzioni dal basso“, perché ci ha colpito il sistema di co-produzione che utilizza.
Sostenere il progetto è semplice: basta registrarsi sul sito, quindi andare sul nostro progetto e cliccare “sostieni”, indicando il numero di copie desiderate e i propri dati.
Non ci sono vincoli e non occorre pagare nulla on-line (è un sito anche eticamente molto serio); per ora è semplicemente un sostegno al nostro libro/progetto.
Una volta raggiunte le 300 copie/quote il progetto si compierà e verrà stampato il libro. Abbiamo 57 giorni di tempo per arrivare a 300 copie e solo allora chi ha effettuato una prenotazione riceverà le proprie copie e potrà pagarle (in vari modi).
Il libro costa 9 euro e i diritti d’autore saranno devoluti in beneficienza.
Nel volume saranno ringraziati tutti i nostri amici sostenitori!
Avevate mai pensato di poter diventare dei produttori editoriali?
Ripartire, da princìpi e valori diversi!
E’ appena uscito il volume “Ripartire“, al quale io ho dato un mio piccolo contributo di riflessione.
Si tratta di un progetto promosso dall’Associazione “Frontiere”, per festeggiare i due anni di attività del web magazine Frontiere News, una realtà nata con lo scopo di raccontare le sfide, le sconfitte e le vittorie dell’Italia interculturale del terzo millennio.

Con più di 120 collaboratori in tutto il mondo, il magazine dà voce a coloro che il cambiamento lo vivono in prima persona, contestualizzandolo in una cornice mondiale di sfide per i diritti fondamentali e per l’integrazione tra i popoli.
Frontiere non è solo web: nel 2011 ha sostenuto i migranti di Lampedusa insieme alla onlus Coevema, ed è partner di progetti di scambi culturali finanziati dall’Ue in Polonia.
Il libro racconta le storie di persone che hanno trovato nella solidarietà, nella cultura e nella riscoperta dell’alterità le chiavi per ripartire, nonostante le crisi globali; emozioni e riflessioni di alcuni tra i più validi intellettuali del panorama internazionale dell’interculturalità; racconti di esperienze in prima linea nella guerra all’indifferenza.
Il progetto ospita contributi del vignettista Vauro, del portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury, di Stas’ Gawronski, Enrico Fontana, Luca Bauccio e tanti altri.
Che si trovi in una Gaza sotto assedio o tra gli indios dell’Ecuador, nei gelidi e affollati moli notturni di Lampedusa o in una metropoli australiana, il vero protagonista di questo volume è l’essere umano, con la sua infinita ricerca di sé e con l’esigenza innata di superare i limiti imposti dalle circostanze.
Qui potete scaricare gratuitamente e leggere l’indice e il mio contributo al volume, che è edito sotto licenza “Creative Commons”.
Il 10% del prezzo di copertina sarà devoluto per sostenere le battaglie per i diritti umani che Amnesty Italia porterà avanti nel corso del 2013. E’ anche disponibile una versione eBook.
Buona lettura e buona ri-partenza a tutti.